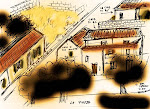Adesso che aveva sul comodino quella scarpetta da calciatore tutta rinsecchita Tommaso non sapeva che cosa fare.






Virginia faceva un solitario, sbattendo le carte al tavolo, contro quel nemico immaginario che aveva davanti per non mettersi a barare. S'incazzava anche, Virginia, con quel nemico immaginario.
"Adesso te ne stai in vacanza e poi vedi cosa fare."
Costanza faceva di sì con la testa e continuava a lavare i piatti.
"Tieni"
Virginia aveva finito il solitario.
Nelle mani di Costanza un rotolino di banconote si bagnava di detersivo.
“E questi?”
"Ho vinto. Adesso te ne stai in vacanza. Poi vedi cosa fare."
Seduto nella poltrona del Re, davanti alla sua televisione, A.C. sentì arrivare la moglie a rovinargli il Rischiatutto.
Chissà come veniva, la foto di Sabina Ciuffini.
Quella delle Kessler era perfetta.
Rinchiuse la macchina dentro la sua custodia.
La musica del Rischiatutto, a Costanza, faceva venire in mente dei pesci rossi,
e Stella che piangeva.
Sulle scale della casa di Rò
ci raccontavamo storie
per farci paura.



Al funerale A.C. ci era arrivato in macchina, con Tatano.
Virginia zoppicando, insieme alla madre di Rò.
Dalia Maria se ne andava come una regina.
Il corteo partiva dalla piazza, percorreva tutta la via principale per arrivare fino quasi alla stazione, poi si dirigeva verso gli uliveti e le vigne, che erano lì per far compagnia ai morti.
Il capostazione aveva chiesto permesso e affidato il comando a Giustina la casellante; Santini non visitò Zio Luigi Canedda, che aveva la tosse.
Percopo era già al cimitero, con gli zoccoli della domenica e dei fiori in mano. Qualcuno rise.
Qualcun altro sputò per terra.
Rocco Berdui tratteneva a stento la moglie, che si strappava i capelli, cercandovi sotto la vita di Dalia Maria, con gli altri figli rotti, ai suoi piedi.
Tre o quattro ragazzi ridevano di nascosto.
Tommaso parlava all’orecchio di A.C., che iniziò a fotografare tutto, da lontano, piegando le ginocchia.
Dalla finestra vidi Dalia Maria che lasciava la piazza, e pensavo che ora
non l’avrei rivista mai più,
e che chissà se si sentiva sola e dispiaceva anche a lei.
Rocco Berdui tratteneva a stento la moglie, che si strappava i capelli, cercandovi sotto la vita di Dalia Maria, con gli altri figli rotti, ai suoi piedi.
A.C. scattava, da sotto il suo borsalino, e scattava.
Non sudava mai,
non sbagliava mai.
Al terzo scatto Rocco si voltò.
Nonno lasciò piano la Pentax a pendere
dal collo.
Tommaso li guardò entrambi, asciugando il sudore
sotto il cappello della divisa buona.
I campanelli delle pecore sul monte
li avrebbero sentiti anche i morti
non fosse stato per la spatola di Ciccittu,




Sono Lola la cagna sola. Non vado con nessuno perchè lei non vuole. Mi ama molto e ogni tanto mi fa uscire dal garage dove dormo di notte. Quando esco incontro lui, che ha 8 anni appena, e pantaloni corti, ma quando mi guarda negli occhi, sembra studiarne ogni singola pagliuzza.
E mi accarezza spesso. Tranne quando passa lei.
Anche lei ha 8 anni appena, ma la sa lunga, e quando inizio ad abbaiare per farle paura lei guarda subito verso di lui, implorante, e allora lui cambia: “Lola! Accuccia! Lola! Guai! Accuccia!” Io mi volto, smettendo di abbaiare, lo guardo, cercando il compenso per il mio silenzio in un suo sguardo, ma quello sguardo è per lei ora. Per me, una guardatina rapida, per vedere se conservo l’ordine. E mi viene quella fitta nel petto.
Quanti figli si possono perdere prima di morire di crepacuore?

I miei piedi si riempiono di spine. Cammino con dei sandali di gomma bianco-trasparente. Gli sterpi suonano come in chiesa.La faccia mi brucia. La luce mi costringe a chiudere gli occhi. Non distinguo il contorno delle cose, se non guardo per terra.
Dò un calcio a una pietra grande. Una specie di lucertola esce da lì sotto veloce, nera, brillante e viscida.Poi un’altra, e un’altra. Se ne forma una fila, di lucertole nere senza zampe, che scorrono come un rigagnolo e fanno rumore d’acqua. Ne seguo il corso. Attraverso un bosco di fichi, poi un canneto. Le pannocchie dei giunchi splendono in controluce di riflessi dorati. Davanti a me, in lontananza, una casa semidiroccata, di cantoni bianchi di calce, tutti sbeccati. La porta, scura come la pece, incorniciata da un grosso ramo di fico. Fra me e la casa, una foresta di cardi viola e lilla, sullo sfondo di un’erba quasi arancione. Ombre lunghe, ormai.Inizio a camminare di nuovo, verso la casa, adesso. Incrociano la mia traiettoria voli di cavallette dalle ali color pesca e turchese, con una striscia nera di velluto. Mi fanno vento, passando.
Un esserino anziano anziano, in pantaloni beige e canottiera bianca. Una testa di capelli biondi biondi quasi bianchi. Emerge dall’ombra pece della porta, alla luce del tramonto.
I miei occhi si riempiono di spine. Non posso tornare indietro. Un mare di lucertole nere alle mie spalle, tempestoso. I miei occhi si riempiono di luce. Mi sveglio.
Babbo.

Intanto, raschiavamo il fondo delle valigie sull’asfalto, salendo verso la chiesa. Mi voltavo di tanto in tanto, con gli occhi bruciati dal sudore, per vedere se la stazione si allontanava abbastanza in fretta. La tenda di strisce di plastica colorata ondeggiava come se qualcuno l’avesse appena attraversata, e non era vero mai.
Ci sfilavano affianco le finestre, una dietro l’altra. Le persiane, a strisce verdi e buio, nascondevano sospiri trattenuti e occhi come periscopi. Ogni tanto ti sembrava di intravedere un niente, uno scintillìo, che poveva essere l’occhio di una vecchia, vestita di nero, o il bagliore di un grano del suo rosario.
Ai muri delle case, poster che sembravano non essere mai stati nuovi e appena messi, ma solo e da sempre vecchi, sparati dal sole, stracciati, a strati, l’uno sull’altro, a comporre poster sempre nuovi, collage: circo Ba../vota.. /Birr..Ichnus../si ringraz.../trigesim..../Pupo in concert.....
Non c’era rumore di uccelli, nessuna automobile in movimento. Niente vento. Solo, lontano, il vago rumore dell’acqua che, se ti concentravi, scendeva nelle vasche del lavatoio comunale o in quella dell’abbeveratoio, o che scorreva come un rigagnolo nel fiume quasi in secca, che chissà perchè lo chiamavano “Su-ma-ttó-ne”, e un giorno l’avrei capito.
Solo quel rumore rinfrescava quel sole cattivo, mentre le cose si muovevano in un sogno bollente, galleggiando sopra l’asfalto, che non era duro, a quell’ora.
Eravamo in tre. Mia mamma, mia sorella, e me, che è sbagliato, ma suona meglio col tre.

Il Cavaliere si sedette quel giorno, come mille altri, a mezzodí, alla tavola apparecchiata solo per lui. Versó il vino, un bicchiere, bianco. Prese il suo coltello, una piccola “pattadese” col manico di corno. Sollevó la forchetta dal tovagliolo candido, fece scattare a serramanico entrambi gli avambracci, di niente, di quel tanto appena che gli consentisse di far arretrare le maniche della giacca solo quel tanto che gli evitava di sporcarsele col bordo del piatto.
Con uno scintillío improvviso, nel grosso anello d’oro, le sue iniziali: A.C.
Avanti Cristo.
Inizió a mangiare.
La luce della finestra che dava sulla strada, penetrava la bottiglia del vino rendendola fosforescente.
In quel momento entró Virginia, zoppicando, nella cucina.
I suoi passi facevano rumore di legno
bello-e caldo-e stagionato. Come i mestoli che usava per fare il sugo.
Il masticare di A.C. faceva rumore di passi nel fango.
Il campanello risuonó per tutte le stanze della casa come le fitte di una pugnalata fredda e improvvisa.


Cosa faceva quel giorno, mio nonno, su quella stradaccia bianca di sassi appuntiti e cunette bruciate, con l’odore delle lumache abbrustolite nelle narici?
La fotografava forse, negli alberi, nel campanile, nei tetti, negli altri, La Vita.
Camminava, lento, quasi a zig zag, poi accelerava, intermittente, si fermava di scatto, con la sua sciarpa di seta, la sua brillantina, il borsalino calato sul volto e la Pentax in mano, perduto in quel sé che non esisteva, se non nel soggetto del suo continuo fotografare.